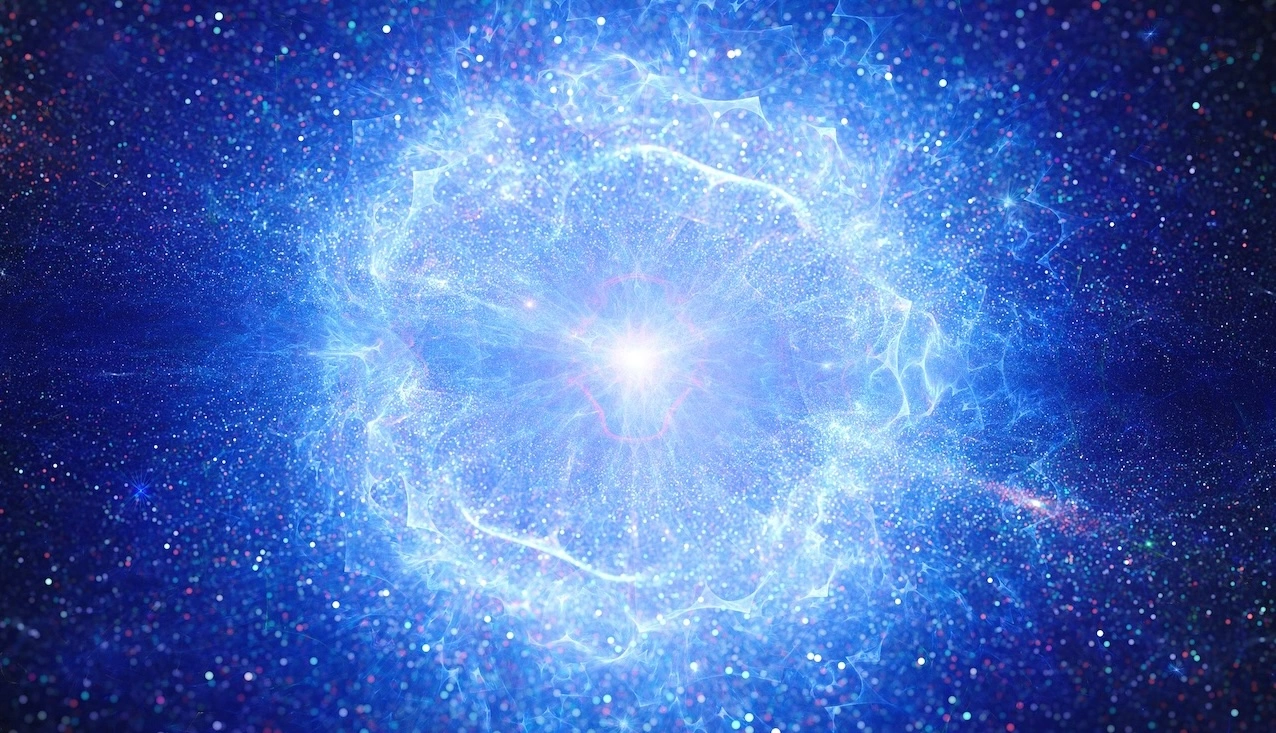
Tra le grandi domande esistenziali occupa un posto speciale quella che recita: “Da dove veniamo?”, ma raramente si hanno le competenze scientifiche per tentare una risposta circostanziata.
Ci aiuta in questo arduo compito, da una prospettiva affascinante, David J. Helfand, che ha scritto Le lancette dell’universo. Ricostruire la storia atomo dopo atomo. Il volume è uscito per i lettori italiani nel maggio del 2024 (Apogeo, traduzione di Corrado Ghinamo). Abbiamo letto per voi il saggio divulgativo.
L’autore
Come sempre, due parole sull’autore.
Ha scritto Le lancette dell’universo David J. Helfand, presidente del Dipartimento di Astronomia della Columbia University, con cui collabora da oltre quarant’anni.
Sackler Distinguished Visiting Astronomer all’Università di Cambridge e presidente dell’American Astronomical Society, Helfand ha pubblicato articoli su Nature, Physics Today, Washington Post e The New York Times.
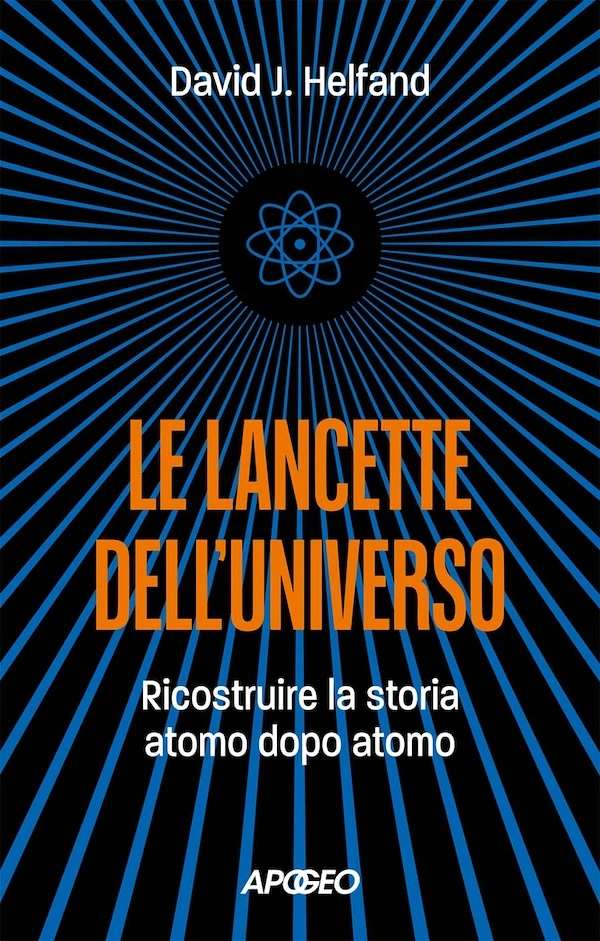
Le lancette dell’universo
Come spesso accade con i saggi, anche per Le lancette dell’universo tocca al sottotitolo fornire, in estrema sintesi, la spiegazione dell’opera.
Ricostruire la storia atomo dopo atomo: il libro si propone dunque di raccontare al lettore non necessariamente alfabetizzato come si possano datare manufatti, fossili umani e animali ma anche eventi fondamentali per la storia umana e del mondo, grazie allo studio degli atomi.
Un’introduzione scientifica
Per quanto di taglio divulgativo, Le lancette dell’universo poggia su concetti scientifici tutto fuorché banali.
Inevitabile, dunque, che la prima parte del saggio prenda per mano il lettore e lo introduca nella conoscenza sempre più approfondita dei protagonisti del volume: la materia, e più nello specifico gli atomi.
C’è un excursus storico-filosofico, che ci racconta come interpretassero la suddivisione della materia gli studiosi antichi (greci, romani ma ad esempio anche indiani).
Arriviamo poi a fare la conoscenza degli atomi, che – nonostante la loro etimologia – sono ovviamente divisibili, e precisamente in “blocchetti ancor più fondamentali, che ricadono in due famiglie, i leptoni e i quark” (p. 22).
Si passa poi a volo d’uccello su uno degli spauracchi dei nostri ricordi scolastici, la tavola periodica degli elementi, e finalmente ci si concentra sulla capacità degli atomi di fornirci notizie sul nostro passato. Per farlo, si introduce il concetto di isotopi. In parole semplici, gli isotopi di uno stesso elemento hanno sempre lo stesso numero di elettroni e protoni, ma differiscono per numero di neutroni (si può anche dire che hanno lo stesso numero atomico ma diverso numero di massa).
Gli atomi e la storia del mondo
I vari isotopi ci permettono, tra le altre cose, di datare un’opera d’arte per scoprire eventuali falsi. Un’indagine su un ipotetico dipinto di Heinrich Campendonk, ad esempio, ha rilevato significative quantità di titanio usato in un determinato pigmento, prodotto per la prima volta sette anni dopo la presunta datazione.
Celebre, poi, lo studio degli isotopi di carbonio per datare il Corano e la Sacra Sindone. Ma le virtù degli atomi per datare il mondo non finiscono certo qui.
Come (e quando) tutto ebbe inizio
Gli ultimi capitoli de Le lancette dell’universo ci offrono scenari davvero grandiosi ed emozionanti.
Uno su tutti: è grazie allo studio degli atomi se si è avanzata la teoria, che nel tempo ha acquistato sempre più credito, della fine dei dinosauri causata da un enorme meteorite. E per enorme intendiamo enorme: del diametro di circa 7 chilometri e del peso di circa 300 miliardi di tonnellate. E l’energia sprigionata sarebbe stata da 10 a 20 miliardi di volte maggiore di quella di una bomba atomica.
Del meteorite si è addirittura riuscito a stabilire con un certo grado di precisione il luogo di impatto col suolo terrestre, la penisola dello Yucatan, e la datazione, circa 65 milioni di anni fa.
C’è di più: ogni frammento di materia che cade sulla Terra porta informazioni preziosissime sui primordi del sistema solare. “Interrogare i suoi atomi ci permette di determinare la sua età e di ricavare informazioni sulla preistoria della nostra casa nel cosmo” (p. 212).
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
Da non perdere questa settimana su Techprincess
🎮 Xbox Games Showcase 2024: tantissimi annunci, tra grandi ritorni e novità
💻A Taiwan per toccare con mano i nuovi AI PC di ASUS. Ed è solo l’inizio
💬Google lancia l’app Gemini in Italia: ecco come provare l’AI su Android e iOS
🧩La strategia di Jansen Huang, il CEO-rockstar: mi ha offerto da bere e chiesto del turismo in Italia
✒️ La nostra imperdibile newsletter Caffellattech! Iscriviti qui
🎧 Ma lo sai che anche Fjona ha la sua newsletter?! Iscriviti a SuggeriPODCAST!
📺 Trovi Fjona anche su RAI Play con Touch - Impronta digitale!
💌 Risolviamo i tuoi problemi di cuore con B1NARY
🎧 Ascolta il nostro imperdibile podcast Le vie del Tech
💸E trovi un po' di offerte interessanti su Telegram!
